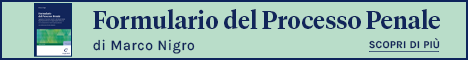
Non senza difficoltà e contrasti tra le opposte forze politiche si è giunti alla definitiva approvazione del d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188 che adegua la normativa nazionale alla direttiva (UE): 2016/343. Nel complesso, il testo normativo non introduce novità particolarmente significative e non pare realizzare quel rafforzamento della garanzia che si attendeva. L’attenzione del nostro legislatore si è concentrata quasi esclusivamente sugli attacchi alla presunzione di innocenza che possono derivare dalle dichiarazioni delle autorità pubbliche o dalle decisioni giudiziarie, senza cogliere l’occasione per intervenire su altri profili della disciplina che meritavano un ripensamento al fine di contrastare le distorte rappresentazioni del procedimento penale cui si assiste per opera dei media.
Despite the difficulties and disputes between the opposing political forces, the Legislative Decree no. 188 of 8 November 2021 adapting national legislation to Directive (EU): 2016/343 was finally approved. In general, the decree does not introduce particularly significant innovations and does not seem to achieve the expected strengthening of the guarantee. The attention of our legislator has focused almost exclusively on the attacks on the presumption of innocence that can derive from the statements of public authorities or judicial decisions without taking the opportunity to intervene on other aspects of the discipline to hinder the distorted representations of the criminal proceedings by the media.
1. Premessa - 2. La presunzione di innocenza nella giurisprudenza della Corte di Strasburgo - 3. I principi espressi nella Direttiva - 4. Le norme di attuazione: a) struttura e ambito di operatività del decreto legislativo - 4. b) i riferimenti in pubblico alla colpevolezza e le informazioni agli organi della stampa - 4 c) le modifiche al codice di procedura penale - 4 d) le disposizioni finali - 5. Considerazioni conclusive - NOTE
La Direttiva (UE) 2016/343 sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo, recava quale termine per l’attuazione il 1 aprile 2018, un termine che il nostro Stato non aveva rispettato, ritenendo che l’ordinamento giuridico nazionale fosse già conforme alle previsioni dell’atto eurounitario [1]. Sennonché, alla luce della relazione sullo stato di attuazione della Direttiva (COM (2021) 144 final), presentata dalla Commissione europea il 31 marzo 2020, emergevano alcune criticità che, seppure non riferite in modo esplicito alle normative di singoli Stati, si potevano riscontrare anche nel nostro ordinamento, giustificando l’avvio di una procedura di infrazione. Nello specifico, i limiti evidenziati riguardavano il rispetto degli artt. 4, 5 e 10 della Direttiva relativi all’esigenza di garantire che l’indagato o l’imputato: non sia oggetto di dichiarazioni di autorità pubbliche, o di decisioni giudiziarie diverse da quelle relative alla responsabilità penale, in cui esso venga pubblicamente presentato come colpevole, nonostante il processo non sia ancora concluso; non sia sottoposto a mezzi di coercizione fisica anche in aula di udienza, durante il processo, o comunque in altre circostanze pubbliche, salvo che ciò sia reso necessario da specifiche esigenze di sicurezza; abbia a disposizione un ricorso effettivo in caso di violazione delle suddette garanzie e cioè un rimedio processuale che – conformemente a quanto precisato nel considerando n.44 – abbia «per quanto possibile, l’effetto di porre l’indagato o l’imputato nella posizione in cui questi si sarebbe trovato se la violazione non si fosse verificata, così da salvaguardare il diritto a un equo processo e i diritti di difesa». Il legislatore [2] ha, dunque, delegato il Governo ad adottare un decreto legislativo per recepire la Direttiva in modo da rendere la disciplina interna più uniforme allo strumento eurounitario. Si è giunti così, non senza difficoltà e contrasti tra le opposte forze politiche, alla definitiva approvazione del d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188: un testo normativo che, nel complesso, non introduce novità particolarmente significative e non realizza, dunque, quel pieno riconoscimento della presunzione di innocenza [3]. Se è vero [continua ..]
Prima di procedere all’analisi delle disposizioni del decreto legislativo, pare opportuno ricordare che la Direttiva ripropone nel suo articolato molti degli insegnamenti della Corte di Strasburgo in tema di presunzione di innocenza. Si deve, infatti, ai giudici convenzionali l’avere contribuito a una crescente valorizzazione della valenza extra-processuale della garanzia sancita dall’art. 6 § 2 Cedu, evidenziando come più spesso il divieto di equiparare l’imputato al colpevole, sotteso alla presunzione di innocenza, sia compromesso da una distorta informazione sulle vicende processuali. In altri termini, è grazie all’elaborazione giurisprudenziale della Corte di Strasburgo che si è superata l’idea che la presunzione di innocenza, come regola di trattamento, operi solo nel contesto in cui si esercita la potestà punitiva, ossia il processo penale, ben potendo essa invece integrare un limite alla divulgazione di notizie relative a una certa vicenda giudiziaria, considerato il ruolo di sanzione atipica che ricopre la notizia. Informare l’opinione pubblica in ordine a un determinato giudizio può, infatti, produrre nel contesto sociale effetti pregiudizievoli nei confronti dell’imputato, con la conseguenza che il divieto di punire prima della condanna ben può risultare violato in ragione di quella gogna mediatica cui l’imputato può essere sottoposto a seguito della divulgazione di notizie relative al suo processo. Ciò non significa che si debba impedire ai media di svolgere il loro prezioso compito informativo. Piuttosto, il fenomeno deve essere governato, tenendo presente che sia la Convenzione (art. 10) sia la Costituzione (art. 21) tutelano la libertà di informazione, cui corrisponde un diritto della collettività ad essere informati [10]. Ed è proprio attraverso l’analisi della giurisprudenza della Corte di Strasburgo sull’art. 6 § 2 della Cedu che emergono le linee di un possibile bilanciamento tra la tutela della presunzione di innocenza e le esternazioni in pubblico dei magistrati e di ogni altra autorità pubblica [11] sulle vicende giudiziarie. In particolare, la Corte ha ritenuto lesive della presunzione di innocenza le affermazioni rese a poca distanza dall’arresto da diverse autorità pubbliche che durante una conferenza stampa avevano indicato l’indagato [continua ..]
Nel recepire gli insegnamenti della Corte europea dei diritti dell’uomo, la Direttiva afferma che «la presunzione di innocenza sarebbe violata se dichiarazioni pubbliche rilasciate da autorità pubbliche o decisioni giudiziarie diverse da quelle sulla colpevolezza presentassero l’indagato o l’imputato come colpevole fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente provata. Tali dichiarazioni o decisioni giudiziarie non dovrebbero rispecchiare l’idea che una persona sia colpevole» (considerandum 16), per poi precisare, che per dichiarazioni pubbliche, rilasciate da autorità pubbliche, «dovrebbe intendersi qualsiasi dichiarazione riconducibile a un reato e proveniente da un’autorità coinvolta nel procedimento penale che ha ad oggetto tale reato, quali le autorità giudiziarie, di polizia e altre autorità preposte all’applicazione della legge, o da un’altra autorità pubblica, quali ministri e altri funzionari pubblici (...)» (al considerandum 17). A queste enunciazioni di tipo programmatico si affiancano disposizioni dal tenore più prescrittivo. Si legge, in particolare, nell’articolato che «gli Stati membri assicurano che agli indagati e imputati sia riconosciuta la presunzione di innocenza fino a quando non ne sia stata legalmente provata la colpevolezza» (art. 3), mentre agli artt. 4 e 5 è sancito il divieto di presentare in pubblico l’indagato o l’imputato come colpevole. In particolare, l’art. 4 della Direttiva 2016/343 si occupa dei riferimenti in pubblico alla colpevolezza, stabilendo che gli Stati membri devono adottare «tutte le misure necessarie per garantire che, fino a quando la colpevolezza di un indagato o imputato non sia stata legalmente provata, le dichiarazioni pubbliche rilasciate da autorità pubbliche e le decisioni diverse da quelle sulla colpevolezza non presentino la persona come colpevole». Precisa poi che, naturalmente, «ciò lascia impregiudicati gli atti della pubblica accusa volti a dimostrare la colpevolezza dell’indagato o imputato e le decisioni preliminari di natura procedurale (…) fondate sul sospetto o su indizi di reità» (§ 1) e che l’obbligo di non presentare gli indagati e gli imputati come colpevoli «non impedisce di divulgare informazioni sui procedimenti penali, qualora ciò [continua ..]
Il decreto si compone di sei articoli. La norma di apertura definisce l’ambito di operatività del decreto. Essa chiarisce che il decreto introduce «disposizioni integrative per il rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza», in conformità alle previsioni della Direttiva e precisa poi che tali disposizioni, conformemente a quanto stabilito dall’atto oggetto di recepimento, si applicano alle sole persone fisiche sottoposte a indagini o imputate in un procedimento penale. Specifica, dunque, che le novità normative non si applicano ai procedimenti diversi da quello penale (civile, amministrativo) e non riguardano le persone giuridiche [17]. La definizione dell’ambito di operatività della disciplina è conforme alla Direttiva, il legislatore nazionale avrebbe potuto comunque assestarsi su uno standard di tutela più elevato o esteso di quello prescritto dall’atto europeo. In particolare, in ossequio a quella giurisprudenza [18] che tende a ricomprendere nella matière penale ogni procedimento (es. amministrativo, tributario) che possa sfociare nell’applicazione di sanzioni la cui afflittività è assimilabile a quella delle sanzioni penali, si sarebbe potuto prevedere che le garanzie poste a tutela della presunzione di innocenza operassero anche nei procedimenti solo ‘formalmente’ non penali e, nell’ottica di una massima espansione della garanzia, anche nei procedimenti relativi alle persone giuridiche, considerato che nel nostro ordinamento il d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 prevede la sottoposizione a processo penale dell’ente quale responsabile amministrativo [19]. La direttiva mira, dunque, a rafforzare il diritto a un equo processo nei soli procedimenti penali [20] e i diritti e i meccanismi di tutela in essa previsti si riferiscono all’intero arco temporale del procedimento penale, senza spingersi oltre la decisione definitiva che ne segna la conclusione. In effetti, come chiarito anche dal considerando 12, la Direttiva trova applicazione «dal momento in cui una persona sia indagata o imputata per un reato o per un presunto reato» (e a prescindere dal fatto che essa «sia messa a conoscenza […] mediante notifica ufficiale o in altro modo di essere indagata o imputata»), sino al momento in cui «non diventi definitiva la decisione che stabilisce in [continua ..]
Alla disposizione di apertura seguono gli artt. 2 e 3, entrambi dedicati alla tutela della posizione dell’imputato dalle possibili aggressioni alla presunzione di innocenza perpetrate attraverso i riferimenti in pubblico alla colpevolezza. Orbene, l’art. 2, rubricato “Dichiarazioni di autorità pubbliche sulla colpevolezza delle persone fisiche sottoposte a procedimento penale”, dopo avere enunciato il divieto, per le «autorità pubbliche» [23] di presentare prematuramente come colpevole la persona sottoposta a indagini o imputata in un procedimento ancora in corso (comma 1), si occupa più nello specifico dei rimedi attivabili dall’interessato in caso di violazione. La prospettiva è quella di fornire una protezione rafforzata al soggetto che abbia subito la violazione, in ossequio a quell’esigenza di effettività della tutela su cui si sofferma l’art. 10 della Direttiva. Nello specifico, pur mantenendo ferma «l’applicazione delle eventuali sanzioni penali e disciplinari nonché l’obbligo di risarcimento del danno» [24], si riconosce all’interessato il diritto di richiedere la rettifica della dichiarazione resa dall’autorità pubblica e, correlativamente l’obbligo di quest’ultima di provvedere sull’istanza entro e non oltre le successive quarantottore (commi 2 e 3). In caso di accoglimento, la rettifica andrà resa pubblica «con le medesime modalità della dichiarazione o, se ciò non è possibile, con modalità idonee a garantire il medesimo rilievo e grado di diffusione della dichiarazione oggetto di rettifica» (comma 4). Infine, nel caso in cui tali modalità non vengano rispettate o l’istanza di rettifica non sia accolta [25], l’interessato potrà rivolgersi al tribunale affinché, ai sensi dell’art. 700 c.p.c., ordini all’autorità pubblica che ha trasgredito il divieto, l’immediata pubblicazione di una rettifica con modalità idonee a garantire il medesimo rilievo e grado di diffusione della dichiarazione lesiva (comma 5) [26]. Se pare apprezzabile l’idea di individuare un rimedio contro le improprie dichiarazioni di colpevolezza da parte dell’autorità pubblica, solleva qualche perplessità il fatto che la richiesta di rettifica debba essere rivolta [continua ..]
L’art. 4 del decreto legislativo interviene sul codice di procedura penale mediante l’introduzione dell’art. 115 bis c.p.p. rubricato “Garanzia della presunzione di innocenza” e l’interpolazione degli artt. 314 c.p.p., 329 c.p.p. e 474 c.p.p. La disposizione di nuovo conio (art. 115bis c.p.p.) riproduce nel contesto codicistico il contenuto dell’art. 4 della Direttiva, stabilendo che sia vietato indicare, nei provvedimenti diversi da quelli volti alla decisione in merito alla responsabilità penale dell’imputato o che presuppongono la valutazione di prove, elementi di prova o indizi di colpevolezza, la persona sottoposta a indagini o l’imputato come colpevole fino a quando la colpevolezza non sia stata accertata con sentenza o decreto penale di condanna irrevocabili. Questo divieto, si precisa nella seconda parte del comma 1, «non si applica agli atti del pubblico ministero volti a dimostrare la colpevolezza della persona sottoposta ad indagini o dell’imputato» [44]. Quanto, invece, ai provvedimenti la cui adozione sottintende la valutazione di prove, elementi di prova o indizi di colpevolezza, il divieto non è assoluto ma relativo ai riferimenti alla colpevolezza che non sono necessari a soddisfare i presupposti, i requisiti e le altre condizioni previste dalla legge per l’adozione del provvedimento (comma 2). A parte le difficoltà di delimitare l’ambito applicativo delle due previsioni che tendono in parte a sovrapporsi, la scelta di prescrivere per le ordinanze cautelari che i riferimenti alla colpevolezza siano contenuti al minimo necessario per corredare il provvedimento dell’impianto motivazionale necessario, finisce per imporre agli organi dell’applicazione ‘acrobazie’ verbali che potrebbero incidere sulla linearità dello stesso provvedimento [45]. L’autorità è, infatti, chiamata a contemperare due esigenze contrapposte: quella di corredare l’ordinanza restrittiva di un apparato argomentativo che giustifichi la limitazione della libertà e quella di tutelare il diritto del destinatario del provvedimento a non figurare come colpevole prima dell’accertamento definitivo dei fatti. Se l’indagato o l’imputato ritiene che la previsione del comma 1, sembrerebbe non anche quella del comma 2 dato il mancato richiamo [46], sia stata violata può, entro [continua ..]
Il decreto legislativo in esame si chiude con la clausola di invarianza finanziaria (art. 6) e con una previsione (art. 5) che, tenuto conto di quanto previsto dall’art. 11 della Direttiva [77], individua nel Ministero della Giustizia l’organo deputato a trasmettere alla Commissione europea, tra gli altri [78], anche i dati relativi al numero e all’esito dei procedimenti disciplinari connessi alla violazione degli artt. 2, 3, 4 del decreto. Si tratta di un adempimento funzionale a monitorare se e come vengano attuati i diritti sanciti nella Direttiva, diritti il cui riconoscimento passa anche per la capacità di garantirne la tutela in caso di violazione. In merito, si può osservare in chiave critica che la scelta di attribuire la legittimazione attiva in capo al solo indagato o imputato, anziché a una autorità garante esterna [79], potrebbe falsare il dato statistico. È verosimile pensare che, in quanto soggetto debole della vicenda, la persona sottoposta al procedimento non sempre versi nella condizione – economica e psicologica – per affrontare anche una ‘battaglia’ parallela a tutela del suo diritto a non essere rappresentato anticipatamente come colpevole e, pertanto, è assai probabile che molte violazioni, anche se reali ed effettive, in quanto non denunciate dall’interessato, non rientrino tra i dati da trasmettere alla Commissione, falsando le statistiche volte a monitorare l’attuazione dei diritti previsti dalla Direttiva.
L’adeguamento alla Direttiva avrebbe dovuto rappresentare l’occasione per assicurare una piena tutela alla presunzione di innocenza, intervenendo anche su profili non direttamente attenzionati dalla normativa europea che non apparissero in linea con tale principio. Si pensi a quelle disposizioni del codice che autorizzano l’applicazione di misure limitative della libertà fondate su un anticipato giudizio di colpevolezza (artt. 274 comma 1 lett. c, 275 comma 1 bis e 2 ter c.p.p.) e a quelle che, in forza di automatismi, permettono che l’applicazione della custodia cautelare si fondi solo su un giudizio relativo al quadro indiziario e non sulle esigenze cautelari, mentre è proprio sul piano teleologico che si coglie la distinzione tra pena e misura cautelare (art. 275, comma 3, c.p.p.) [80]. Le modifiche apportate dal decreto legislativo muovono, invece, in un’unica direzione, quella indicata dalla Direttiva. Gli obiettivi perseguiti sono: da un lato, evitare che la persona indagata o imputata sia rappresentata nelle dichiarazioni rese al pubblico, negli atti processuali e nei contesti in cui compare al processo, come colpevole, prima che si sia pervenuti ad una decisione definitiva in ordine alla sua responsabilità, dall’altro, limitare la diffusione di notizie sui procedimenti in chiave colpevolista sui media, ridefinendo i rapporti tra gli organi inquirenti e la stampa. Se tale scelta rappresenta di per sé un limite – peraltro dichiarato [81] – dell’intervento normativo, più criticabile è il fatto che il decreto legislativo, anche nella parte in cui recepisce le indicazioni della Direttiva, non realizzi quell’accrescimento di tutela che si auspicava. La rimodulazione dei rapporti tra organi inquirenti e stampa avviene sulla base di una mera rivisitazione di disposizioni che già operavano nel nostro sistema in forza del d.lgs. 20 febbraio 2006, n. 106 [82], senza che contemporaneamente si siano pensate delle norme di garanzia rivolte agli organi della stampa per proteggere i diritti della persona sottoposta a procedimento penale. Le novità introdotte non paiono idonee a contrastare e impedire quelle distorte rappresentazioni del procedimento penale cui si assiste per opera dei media. Le regole fissate per l’autorità pubblica non garantiscono dagli attacchi alla presunzione di innocenza che possono essere [continua ..]