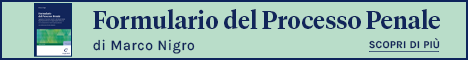La Direttiva 9 marzo 2016, 216/343/UE corrisponde ad un importante progetto dell’Unione, vocato ad accrescere la fiducia reciproca tra gli Stati membri tramite una cultura giudiziaria comune. Poche le novità addotte dallo strumento europeo sul piano delle garanzie, con una eccezione: la Direttiva è in grado di portare significativi mutamenti sul piano dei rapporti tra media e processo penale e forse anche sulla disciplina dei poteri officiosi del giudice in materia di prova.
The presumption of innocence in the Directive no. 216/343/EU: per aspera ad astra The Directive no. 216/343/EU of 9 March 2016 corresponds to an important EU project, suited to increase mutual trust between Member States through a common judicial culture. Almost non-existent what’s new adduced by the European Instrument on the level of guarantees, with one exception: the Directive is able to bring significant changes in terms of the relationship between the media and the criminal trial and perhaps also on the regulation of officious judge’s powers of evidence.
PREMESSA
Entro l’1 aprile 2018, gli Stati dell’Unione sono chiamati a conformare il proprio diritto interno alla Direttiva 9 marzo 2016, 2016/343/UE.
Testualmente intitolata al “rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali”, la Direttiva evoca argomenti di massimo rilievo per i sistemi processuali interni ed anche a livello subliminale una simile nomenclatura sottintende aspetti dirompenti; la conformazione concreta del prodotto legislativo è però schiettamente inadeguata, composta com’è di canoni che volano basso, arrivando solo in certi punti a sfiorare la sostanza dell’intitolazione eroica [1].
Di più: la Direttiva risulta, in verità, inappagante anche rispetto al suo moto d’origine, ovvero quel Libro Verde sulla presunzione d’innocenza del 4 aprile 2006, che la Commissione delle Comunità europee aveva distribuito attraverso gli Stati membri, con richiesta di risposta entro il 9 giugno del medesimo anno.
Ma si proceda con ordine. Nei considerando 4 e 5 della Direttiva, è leggibile una confessione: il principio del riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie «presuppone che gli Stati membri ripongano fiducia reciproca nei rispettivi sistemi di giustizia penale», ma di fatto accade che «sebbene gli Stati membri siano firmatari della CEDU e dell’ICCPR, l’esperienza ha dimostrato che questa circostanza in sé non sempre assicura che vi sia un grado sufficiente di fiducia nei sistemi di giustizia penale di altri Stati membri» (considerando 4 e 5).
In termini più espliciti, in effetti, la Raccomandazione del Parlamento europeo del 7 maggio 2009 [2], sullo sviluppo di uno spazio di giustizia nell’Unione, tratteggiava la seguente congiuntura: «il livello di realizzazione nel campo della cooperazione giudiziaria penale è stato piuttosto modesto … mentre si riscontrano sviluppi soddisfacenti in altri campi, quali la cooperazione in materia civile», sicché «l’attuazione del principio del riconoscimento reciproco … è ancora lungi dall’essere soddisfacente e deve essere accompagnata da un insieme uniforme di garanzie e tutele procedurali» (considerando D e I).
Nella stessa prospettiva, risalendo a ritroso nel tempo, il Libro verde sottolineava come il principio del reciproco riconoscimento fosse destinato a funzionare efficacemente «solo se esiste fiducia negli altri sistemi giudiziari e se ogni individuo nei cui confronti sia stata emessa una sentenza giudiziaria straniera ha la certezza che essa è stata adottata secondo giustizia» (punto 1.1).
In buona sostanza, ecco il punto: secondo le stesse istituzioni europee, il sacro Graal del mutuo riconoscimento delle decisioni giudiziarie si [continua..]