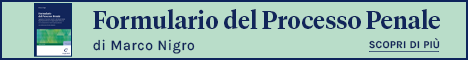
La Corte di Cassazione ha ritenuto che, in tema di acquisizione dei dati contenuti nei cd. tabulati telefonici, la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione Europea del 2 marzo 2021 (H.K., C-746-218) non possa trovare diretta applicazione fino all’intervento del legislatore in quanto i principi in essa richiamati sono del tutto generici e, dunque, non direttamente applicabili. Di qui, la ritenuta applicazione dell’art. 132 del d.lgs. n. 196 del 2003 sul quale, però, è successivamente intervenuto il legislatore con il decreto-legge n. 132 del 2021 convertito con la legge 178 del 23 novembre 2021 recependo le indicazioni della CGUE sulla necessaria indicazione di specifiche fattispecie di reato per le quali è possibile richiedere l’acquisizione dei dati telefonici e telematici nonché sull’intervento autorizzativo di un organo terzo rispetto alle parti, quale è il giudice.
The Court of Cassation ruled that – with regard to the acquisition of data contained in the so-called telephone records – the judgment of the Court of Justice of the European Union of 2 March 2021 (H.K., C-746-218) can’t be directly applied in Italy until the legislator has adopted a decision, since the principles contained in the EU ruling are completely unspecific. According to these reasons, the Court of Cassation considered the Article 132 of Legislative Decree no. 196 of 2003 to be applicable. However, the Legislator subsequently acted on this provision with the legislative decree No. 132 of 2021, converted by Law 178 of 23 November 2021, which received the indications of the CJEU on the necessary indication of specific cases of crime for which it is possible to request the acquisition of telephonic and telematic data. It also ruled that the approval of a third body other than the applicant, such as the judge, is necessary.
1. La giurisprudenza di legittimità sulle modalità di acquisizione dei dati esterni del traffico telefonico e telematico - 2. La disciplina dell’art. 132 del d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. - 3. Segue. L’intervento del Legislatore del 2021 - 4. Le possibili problematiche applicative - NOTE
La seconda sezione della Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso avverso un’ordinanza ex art. 309 c.p.p. emessa dal Tribunale di Brescia in merito al provvedimento del Giudice per le indagini preliminari che aveva disposto la misura della custodia cautelare in carcere dell’indagato in relazione al delitto di associazione per delinquere finalizzata a commettere reati contro il patrimonio oltre che per altri reati satellite. Il ricorrente ha lamentato l’inutilizzabilità degli elementi di prova raccolti: in particolare, con riferimento alla data retention in relazione alle acquisizioni del pubblico ministero, sulla scorta dei principi sanciti dalla recente sentenza del 2 marzo 2021 della Corte di giustizia [1]. La pronuncia ha chiarito alcuni fondamentali aspetti della disciplina della data retention evidenziando la necessità di una stretta proporzionalità tra limitazioni dei diritti fondamentali ed esigenze di sicurezza pubblica, e quindi di un limite alla possibilità di acquisire in sede processuale i dati di traffico telefonico, attivabile per i soli procedimenti per gravi reati o per gravi minacce per la sicurezza pubblica; con, in più, l’indispensabile condizione dell’autorizzazione ad opera di un soggetto terzo rispetto al richiedente. L’aspetto più originale della pronuncia riguarda, certamente, l’esigenza di rendere selettiva e mirata la stessa conservazione dei tabulati, limitandola in ragione del tipo di dato, del mezzo di comunicazione considerato, della durata della conservazione, delle persone coinvolte (che devono avere un collegamento almeno indiretto con la commissione di gravi reati), finanche di criteri geografici che limitino la conservazione ad aree caratterizzate da rischi specifici. Si tratta di criteri che finiscono con il mutare la natura stessa della data retention come misura preventiva e, in quanto tale, applicabile massivamente, in vista di un’acquisizione, soltanto eventuale e retrospettiva, in sede giudiziaria [2]. Ritornando al caso oggetto della sentenza, se accolti, questi dicta europei avrebbero comportato l’espunzione, dal compendio investigativo, di un indizio fondamentale per l’identificazione del ricorrente. Nel rigettare le doglianze difensive i giudici di legittimità hanno chiarito che la portata dei precetti della Corte di giustizia è eccessivamente generica quanto [continua ..]
Eppure, la disciplina dell’art. 132 del d.lgs. n. 196/2003 appare, rebus sic stantibus, in contrasto con i principi esplicitati dalla Corte sovranazionale nella sentenza del 2 marzo 2021 [5]. Infatti, la conservazione dei dati prevista dalla disciplina interna non contempla una limitazione per particolari fattispecie di reato, né impone il controllo di un’autorità indipendente, come potrebbe essere il giudice. La questione è stata già più volte affrontata sia in dottrina che in giurisprudenza con riferimento a precedenti arresti del giudice sovranazionale [6]. Una nota pronuncia Digital Rights Ireland Ltd. dell’8 aprile del 2014 della Corte di giustizia ha ritenuto che alcune disposizioni della direttiva UE 2006/24/CE fossero in contrasto con il diritto fondamentali alla vita privata e familiare, nonché con quelli alla protezione dei dati di carattere personale e alla libertà di espressione e di informazione, in quanto il trattamento dei dati di traffico telefonico e telematico, nonché la loro archiviazione, consente di avere precise indicazioni sulla vita privata dei cittadini, sulle loro abitudini quotidiane, sui luoghi di dimora e residenza abituali e, finanche, sulle loro relazioni sociali. Secondo la Corte sovranazionale si rende necessario, dunque, rispettare il criterio di proporzionalità per salvaguardare i diritti e le libertà rispetto ad una così penetrante invasione nella loro sfera privata. Nella successiva pronuncia Tele2 e Watson del 21 dicembre 2016 la Corte di giustizia ha affermato che gli standard individuati dalla sua giurisprudenza sono da considerarsi imperativi all’interno delle legislazioni nazionali, che sono, a loro volta, tenute al rispetto dell’art. 15, par. 1, della direttiva 2002/58/CE, così come modificata dalla direttiva 2009/136/CE, dovendosi interpretare in collegamento con gli articoli 7, 8, 11 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. In considerazione delle frizioni tra la normativa interna e quella sovranazionale, il legislatore ha provveduto a riscrivere, in più momenti, la disciplina del codice della privacy [7]. In origine, l’art. 132 del d.lgs. n. 196/2003 [8] stabiliva, genericamente, che i dati relativi al traffico telefonico dovessero essere conservati dal fornitore per ventiquattro mesi per finalità di accertamento e [continua ..]
La citata sentenza della Corte di giustizia del 2 marzo 2021 ha avuto il merito di riaccendere il dibattito sulla normativa interna della data retention [16]. I contrasti tra i giudici di merito circa la corretta interpretazione delle indicazioni fornite dalla Corte di giustizia hanno sollevato, invero, non pochi dubbi sull’inerzia del legislatore. Ci si è chiesti, in particolare, quando e come il legislatore sarebbe intervenuto, con quali conseguenze per i procedimenti in corso e ci si è interrogati sulla condivisibilità o meno delle argomentazioni contenute nella sentenza della Corte di giustizia [17]. Le convinzioni della giurisprudenza interna sulla validità della normativa di cui all’art. 132 del d.lgs. 196 del 2003 sono apparse non irrobustite dal confronto con il nucleo essenziale dei diritti della persona riconosciuti dalla normativa sovranazionale. Negli ordinamenti nazionali, ed in particolare in quello italiano, si è sempre preferito ritenere necessario che a soccombere fossero proprio i diritti riferibili alla sfera privata dei singoli piuttosto che esigenze investigative o di accertamento dei fatti [18]. Nonostante le resistenze, il legislatore – probabilmente per evitare un’incontrollabile oscillazione giurisprudenziale – è intervenuto sul tema della modalità procedurale di acquisizione dei dati esterni di traffico telefonico e telematico a fini di indagine [19], con una decretazione di urgenza – in un provvedimento nel quale sono state inserite, come accade spesso, numerose disposizioni nelle più disparate materie [20] – che non ha mancato di sollevare dubbi su plurimi aspetti. L’intervento, senza modificare le tempistiche di conservazione dei dati, mira a circoscrivere la possibilità di acquisirli ai procedimenti che hanno ad oggetto l’accertamento di reati gravi, selezionati quoad poenam, e attribuendo il controllo preventivo al giudice, salvo i casi d’urgenza per cui si è prevista una disciplina tutt’affatto difforme a quella di cui all’art. 267, comma 2, c.p.p. Non pochi i dubbi che ne sono derivati. La disciplina come delineata dal decreto-legge, risultava in alcuni punti imprecisa: basti pensare che il comma 3 dell’art. 132, che disciplinava la procedura ordinaria, statuiva che «i dati sono acquisiti presso il fornitore con decreto motivato del giudice [continua ..]
Dalle considerazioni svolte appare chiaro che il rapporto tra privacy e procedimento penale è sempre stato caratterizzato da un fisiologico squilibrio. Il diritto alla protezione dei dati personali della persona indagata sia dei soggetti occasionalmente coinvolti nel procedimento è risultato, sistematicamente, soccombente rispetto alle esigenze proprie dell’accertamento penale. Si è sempre ritenuto che il fine del procedimento, e delle indagini preliminari, in particolare, potesse giustificare la compressione del pur fondamentale diritto alla privacy. L’accertamento penale è uno straordinario meccanismo di raccolta, selezione, interconnessione e raffronto di informazioni relative a persone identificate o identificabili. Nessuna indagine, si dice, andrebbe a buon fine qualora i suoi risultati fossero consultabili prima del tempo, ossia qualora i soggetti coinvolti nell’accertamento fossero titolari dei classici diritti di informazione, accesso, rettifica e cancellazione. Epperò, il sempre crescente grado di intrusività degli strumenti investigativi impone di trovare un punto di equilibrio, che deve essere valutato secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità, pena il sacrificio nel suo nucleo essenziale dell’istanza soccombente, cioè la privacy. Sulla base di tali premesse, occorre valutare se il recente intervento operato dalla l. 23 novembre 2021 n. 178, che ha convertito il richiamato decreto legge 30 settembre 2021, n. 132 [28], abbia effettivamente dissolto i dubbi sulla legalità dell’acquisizione dei tabulati rispettando pienamente i dettati sovranazionali sul tema. Sembrerebbe essersi posto, sul piatto della bilancia, il rapporto tra le esigenze dell’accertamento penale e l’aspirazione dell’individuo ad impedire la conoscenza dei dati che lo riguardano; resta, forse, il diritto alla trasparenza ed alla accessibilità di tali dati, nonché le valutazioni circa la loro modalità di raccolta e conservazione da parte dei provider. Nonostante le problematiche irrisolte, quest’ultima novella – dal respiro ‘garantista’ [29] – ha recepito quell’indirizzo giurisprudenziale che riteneva applicabile la più garantita disciplina delle intercettazioni all’acquisizione dei tabulati, ritendendo che il grado di invasività dello strumento necessitasse di un [continua ..]